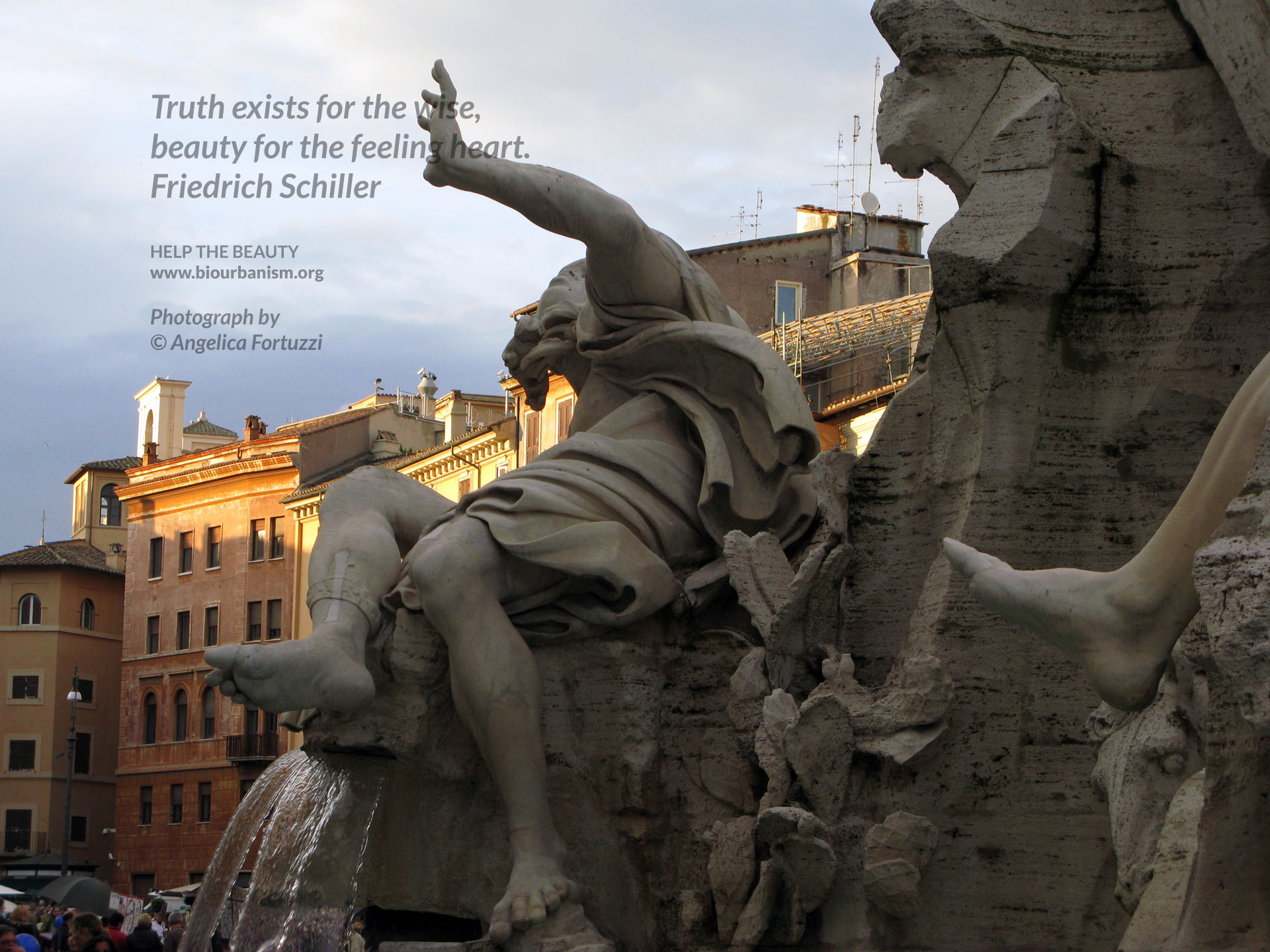Il Grande Cretto salvato da una panda a noleggio
di Angelo Abbate
Sono stato a Gibellina vecchia sull'inizio dell'estate di due anni fa ormai, fu una tappa scelta settimane prima per colmare la curiosità che fin da studente mi attraeva verso "un esperimento unico al mondo" in una terra unica al mondo. Ne conoscevo per capisaldi la cronistoria generativa ma soprattutto mi sforzavo ad immaginare le reazioni degli abitanti, dei sopravvissuti, alla scelta apparentemente folle di questo artista invitato, tra gli altri, a contribuire con la propria firma alla "rinascita" di quel paese.
In effetti mai contributo di rinascita fu, almeno metaforicamente, più infausto e beffardo: migliaia di metri cubi di cemento tombarono le macerie sigillando, come nel più glaciale e postatomico dei cimiteri, i resti di una comunità trapiantata altrove e negando "per sempre" un risveglio della rovina. Di recente il completamento di quell’opera e il riaccendersi della polemica su di essa mi ha spinto a ripercorrere la mia esperienza.
Quell'estate decidemmo con Fabio ed Alessio di raggiungere il grande cretto con il pandino noleggiato, non si trattò della scelta "comoda" ma piuttosto dell'unica disponibile. E a dirla tutta di comodo non ci fu nulla. La vecchia provinciale che portava ai "resti" del paesello era chiusa per frana da indeterminato tempo e muniti di imprudente coraggio decidemmo di imboccare una impraticabile stradina di campagna probabilmente buona per portare a "Frittole". Infatti, dopo aver attraversato campi di frutteti e greggi in completo ozio la stradina diventò sentiero e le nostre certezze, assieme al nostro coraggio, iniziarono a vacillare. Per fortuna però i tre incauti sfigati ebbero la loro botta di culo e incontrarono un poggiorealese mezzo contadino e mezza guardia forestale che, nel più classico quadretto sull'ospitalità meridionale, si prodigò per tirarli fuori dai guai. Non solo il buon Pietro ci condusse fuori dal sentiero offrendosi perfino di guidare nei tratti ardui a rischio dirupo (<<Ragazzi! Ve la salgo io 'sta machina?!>>) riportandoci sulla provinciale oltre la frana ma rimase con noi tutto il pomeriggio assicurandosi che riuscissimo a vedere tutto ciò che ci poteva interessare. Arrivammo alla vecchia Gibellina un quarto alle quattro sotto un sole da piena estate. Ci fermammo impietriti difronte al paesaggio che ci si aprì davanti, una sensazione alienante come fossimo entrati in un vecchio campo di concentramento nazista. In effetti l'opera non celebrava certo la vita ed il fatto che in quel momento fossimo gli unici visitatori amplificava questa sensazione quasi come se quel cemento non ci volesse lì a profanarlo con i clic delle nostre macchinette. Lo attraversammo comunque. Dentro quei solchi nell'immenso monolite di calcestruzzo mi sforzavo di percepire i frammenti di vita quotidiana sigillati pochi centimetri sotto la crosta, quello strato biologico costipato ed incapsulato come fosse materiale radioattivo. Eccolo il paradosso, il lato "oscuro" dell'opera, il fondamento di tante polemiche.
Io sono sempre stato un ammaliato dall'arte, soprattutto contemporanea, dal gesto folle di un genio in una ricerca estetica nuova, non convenzionale. Ho però anche imparato nel tempo (e le cene-riunioni della Società di Biourbanistica a casa del direttore hanno dato il loro contributo...) a superare la ricerca di alieno e di astratto di certe correnti valorizzando i contenuti biofilici di altre. Il grande cretto rappresenta dunque per me il "punto di rottura" di due filosofie artistiche in conflitto ma per certi versi anche il loro "punto d'incontro". Quando Burri fu invitato a Gibellina tutti pensavano che avrebbe potuto realizzare qualcosa nella città di nuova fondazione dove già altri illustri personaggi si erano dedicati con realizzazioni di risonanza mediatica, forse anche lo stesso Burri lo pensava, ma non andò così. Si racconta che quella nuova città non lo ispirava, in quel luogo non sentiva di poter lasciare nulla. Forse il maestro soffriva la rigida struttura della città nuova? Da quella materia "schematizzata" in palazzi e strade non riusciva a trarre la poesia per la quale divenne artista di fama mondiale? Burri all'epoca aveva già da tempo iniziato la produzione dei "cretti" e la sua ricerca sulla consunzione del residuo aveva raggiunto una profondissima riflessione sulla vita, per definirla come piace ai critici, una dimensione cosmica.
Mi piace pensare che attraversando quelle strade di macerie cosparse di frammenti di vita quotidiana l'artista abbia portato la sua poetica alla massima espressione attraverso il sacrificio di inumazione della rovina. Un processo "sublime" che richiama alla memoria il culto dei defunti nell'Antico Egitto dove il sarcofago (nebankhossia ovvero “Possessore di vita”) custodiva il corpo per l'eternità.
Non una operazione megalomane e presuntuosa sulla sacralità di un vecchio borgo, non l'irrispettosa e speculativa distruzione della memoria di una comunità e della sua materia nobile ma un gesto che eleva quella stessa materia a "carne della città" e che come tale le riserva un religioso culto di sepoltura.
La rovina architettonica, bruscamente generata dall'evento catastrofico, e il suo carico di superfetazioni biologiche, di oggetti quotidiani, letti, armadi, piatti, spazzolini da denti (…), è stata sigillata da un sudario pietrificato elevando le macerie a corpo della città consegnato al tempo infinito.