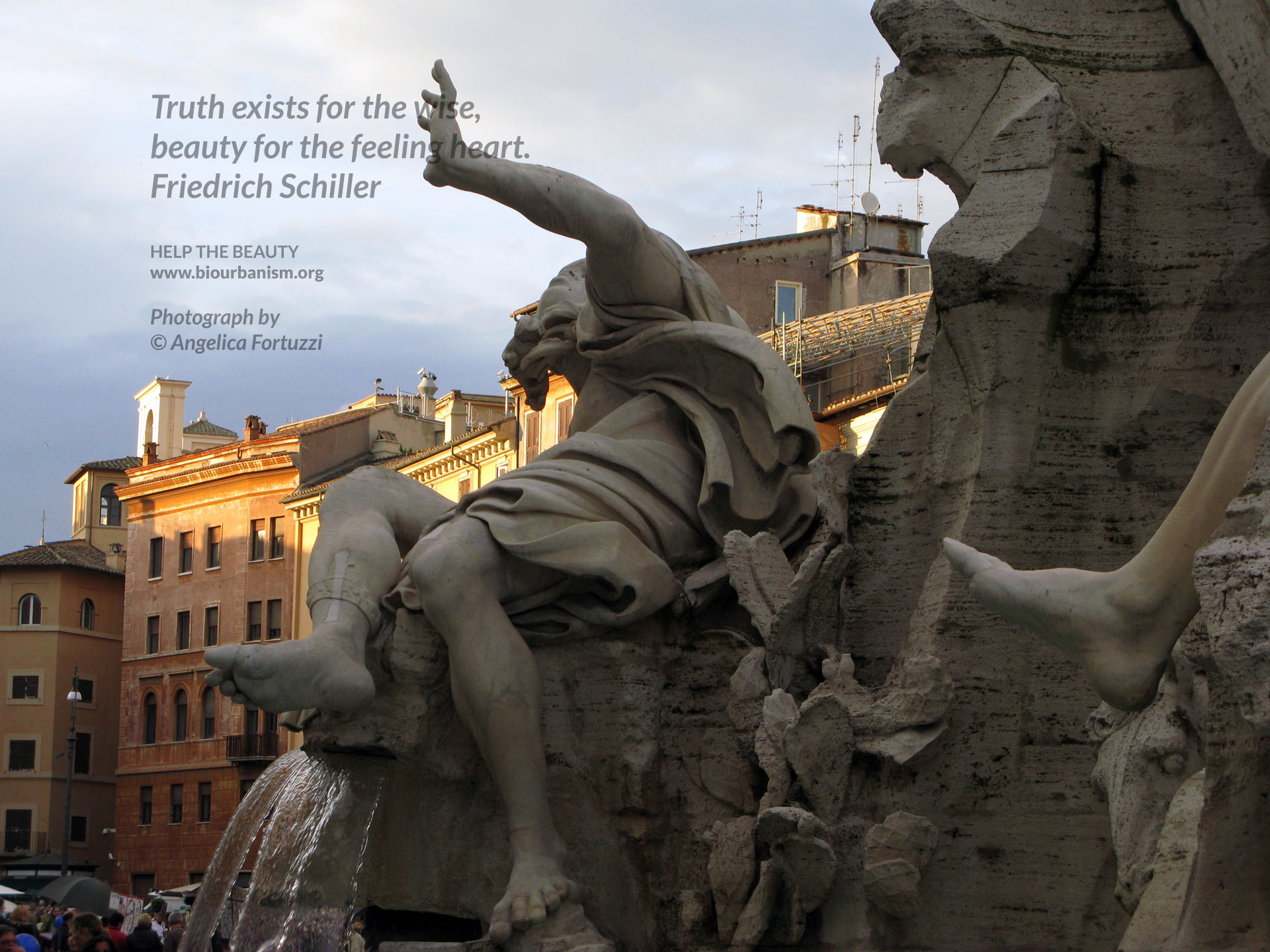La pietra di Cilla. Arte e identità dei luoghi del Sud
di Guglielmo Minervino
L’Italia dell’estremo Sud ha una storia dalle radici assai profonde che attingono linfa da tutte le culture mediterranee, fin da quando l’appellativo Magna Grecia rappresentava una sorta di marchio identitario e garanzia di elevata cultura, qualità dei prodotti egrande valore delle comunità che ne abitavano il territorio. La complessità che permea ogni angolo del Sud è profondamente espressa, e celata allo stesso tempo, non solo nella sua architettura fisica ma soprattutto in quella sociale, delle tradizioni d’ogni giorno, nella cultura del saper fare. Si può scovare nei nomi d’ogni luogo, poiché finanche la più piccola nicchia, dal borgo al bosco che lo abbraccia, è resa viva e si fregia d’una storia tutta sua: questa ne scolpisce l’identità e ne racconta nascita ed avventure alle nuove generazioni attraverso la voce di chi ha il compito di insegnante e custode dell’esser figlio di quella terra. Esiste un ponte tra realtà fisica, tangibile, esperibile, e realtà spirituale, comune ad ogni singolo, che diventa forza ed arma all’occorrenza per difendere i luoghi dei quali gli individui si riscoprono radici.
L’identità costruita giorno dopo giorno è però appesa ad una corda assai sottile, che vibra d’una voce narrante sempre più dispersa nel caos della società globale; attaccata a luoghi fisici ormai ignoti a molti, cancellati dall’arroganza di costruire il nuovo senza ricordare che ogni segno ha bisogno d’una lavagna per poterli scrivere; e che creare non vuol dire radere al suolo, ma piuttosto gettare una luce su ciò che già c’è, portarlo all’attenzione, alla riflessione per l’animo di chi vi si scontra e d’improvviso diventa personaggio d’una storia nella quale è entrato, foss’anche inconsciamente.
Diviene quindi essenziale nel processo di rigenerazione delle città d’oggi riscoprire le storie dei luoghi per toglier via da loro un po’ di polvere, e facilitare l’opera mai interrotta del racconto, agevolare la voce dell’identità che aggrega le comunità.
La creatività e l’opera di cesello dell’artista che scava nell’animo del luogo permette di portarne alla luce l’essenza, il cuore. È la dignità di una vocazione oggi relegata in fondo alla scala di ciò che è utile.
In un piccolo paesino della Calabria tirrenica, San Lucido, il giovane artista locale Salvatore Plastina ha provato a restituire voce a quella che è una delle storie più radicate nel borgo. La storia è l’autobiografia della comunità, dei suoi valori, delle sue tradizioni e dell’animo dei suoi abitanti. Scolpendo la protagonista egli ha conferito un volto al luogo, suscitando l’interrogazione dei passanti che fa ripartire il racconto ormai quasi perduto. L’aggiunta di questo piccolo segno al territorio è delicata, sembra farne parte da sempre.
 |
Riportiamo qui sotto la vicenda recuperata e ricondivisa dalla scultura, nelle parole del suo autore, Raffele Staffa.
La Pietra di Cilla
La pietra è uno spuntone di roccia chiuso, a mo’ di culla, tra due piccoli promontori; nella sua rientranza, questo luogo, par di formare una cavità a guisa di grande conchiglia nella quale l’eco dei frangenti si ripete, diventando sempre più alto e cupo e lacerante come appello disperato. Quel masso che si erge al centro viene indicato dal popolo come la “Pietra di Cilla”.
Si racconta che Cilla era la figliuola di Vicienzu, il nocchiero di Ciccuzzu. Bellissima bruna, slanciata, perfettamente modellata nel suo costume paesano. Occhi neri vellutati sino al bulbo, parlanti, chiaramente manifestavano l’intelligenza e la esuberante vitalità della nostra razza. Bella, naturalmente bella, senza creme o belletti e, se atteggiava la bocca al sorriso, era un modesto atteggiamento pieno di grazia e di bontà. Era il tipo di fanciulla di quel tempo che bastava vedere una volta sola per fissarsela nella mente, non deformata dall’artifizio che rende la donna figura fisico-morale variabile dall’oggi al domani.
La madre, da buona massaia, aveva insegnato alla figliuola l’arte del filare e del tessere ed aveva voluto ch’ella sapesse un po’ leggere e far di conti, tanto che Cilla, fatta grandicella, leggeva correttamente alla madre il libro della vita dei santi Martiri e ciò concorse a formare in Cilla un carattere fermo e risoluto.
In seguito la madre si ammalò gravemente ed Ella fece voto alla Madonna di una perpetua verginità, per ottenerne la guarigione. La mamma guarì, ed Ella, quantunque fosse richiesta in moglie dai più prestanti giovani marinari, dovette rifiutare per quell’obbligo del voto. Anche il principe la incontrò un giorno ch’Ella andava ad attingere acqua alla fontana, un po’ fuori dell’abitato, le presentò i migliori complimenti e qualche proposta che la fece arrossire, ma non si smarrì: “quello che mi chiedete non rientra nei vostri diritti feudali” rispose e gli voltò le spalle, senza nemmeno un saluto.
Un triste giorno di ottobre le paranze furono improvvisamente colte dal fortunale e fu difficile tornare a riva. Della popolazione, quelli che potevano dare il loro aiuto scesero tutti, mollando cime, aiutando a tirare a secco i legni e con maggiore interesse Cilla perché a mare era suo padre, imbarcato sulla barca di Ciccuzzu. Vi fu, dovuto ad imperizia, un momento d’incertezza ma tutte le barche furono tratte in salvo. Ciò si dovette al buon suggerimento del mozzo Tuturo, il quale volle che, per andare a riva, non si dovesse tagliare la rema, ma abbandonarsi ad essa e governare bene la barca. Così le barche stracquate (spinte a secco) a cento metri dal solito punto d’approdo, poterono mettere in salvo l’equipaggio senza danni. La valentia del mozzo fu tenuta in gran conto da Cilla e si ricordò in quel momento come Tuturo fosse trai suoi pretendenti; ne arrossì e chiese perdono alla Madonna. Ma guarda caso, anche Tuturo, in quel momento, pensò come l’animo di Cilla, per quella circostanza, potesse essere più bendisposto ad un riconoscente consenso e rinnovò la richiesta. Ma Cilla rifiutò ancora per fedeltà al voto. A rimuoverla non valsero le buone ragioni della madre che le faceva presente come lei ed il padre fossero inoltrati negli anni, come a San Lucido non avessero parenti prossimi e nessuno avrebbe più cura di lei. Cilla era sempre ferma in un ostinato rifiuto. Pensò allora la buona donna di rivolgersi al parroco perché la persuadesse ad acconsentire e don Nicola Buglio intervenne! Le fece comprendere come il matrimonio sarebbe stato un sacrificio che la Madonna avrebbe gradito, perché il matrimonio impone obblighi gravi e preoccupanti. Le ricordò come la Vergine stessa all’annunzio dell’angelo altro non seppe rispondere che: “ECCE ANCILLA DOMINI FIAT MIHI SECUNDUM VERBUM TUUM”. Considera, suggerì il parroco, la richiesta di Tuturo come manifestazione del Divino Volere, accetta, perché a sciogliere il voto penserò io. E Cilla acconsentì.
Il matrimonio fu celebrato con tutte le modalità d’uso. Ciccuzzu fu compare d’anello e condusse la sposa all’altare, davanti a un lungo corteo. Al ritorno vi fu un generoso convito, al quale furono presenti tutti i nocchieri e i padroni di paranza, ed alla bicchierata tutte le ciurme n’ebbero d’avanzo. Tuturo era felicissimo per la realizzazione del suo sogno e sua mamma, riconoscendo che Cilla era una ragazza tanto assennata, pur se giovane, le affidò, sin dal primo giorno, la direzione della casa.
La felicità parve essere entrata in quella famiglia educata al timore di Dio. Tutti lavoravano e nulla mancava a quanto potesse occorrere. Tutto era pace e tranquillità. Un giorno Tuturo uscì per tempo di casa e Cilla, al suo svegliarsi, trovò la casa cosparsa di fiori: sul tavolo, sulle sedie, persino sul letto, fiori dappertutto! Fu Tuturo a ricordare che quel giorno ricorreva il suo compleanno. E fu giorno felice.
Padron Peppe che si era, col suo tre alberi e la famiglia, trasferito a San Lucido, ebbe modo di valutare la perizia e l’abilità di Tuturo nel suo mestiere ed un giorno gli propose di far parte della sua ciurma. Tuturo accettò e bastò un breve periodo di navigazione perché acquistasse maggior pratica ed esperienza nel mestiere. In breve tempo apprese gli aspetti tecnici della navigazione, approfondì la conoscenza della rotta-bussola e tante cognizioni che lo resero abile capitano di barche. Ebbe abitudine di consultare la bussola ed il barometro, di guardare il cielo e scrutare l’immensa distesa del mare. Così Tuturo era un po’ tutto: nostromo, e nei momenti difficili anche timoniere.
Padron Peppe, ormai vecchio, si ritirò dalla navigazione e lasciò l’incarico a Tuturo che si dimostrò degno ed abile nocchiero della barca e dell’azienda.
Cilla che, ormai, aveva imparato a calcolare i tempi della navigazione e quelli necessari alle operazioni di carico e scarico, il giorno dell’arrivo si faceva trovare, puntualmente, su quella pietra a scrutare l’orizzonte e, quando dalla sagoma e dal gioco delle vele il bastimento era stato identificato, incominciava la festa: scampanio, spari di mortaretti, allegria completa, giù la popolazione a complimentare la ciurma e a dare una mano di aiuto, qualora occorresse.
Qualche anno dopo gli sponsali venne il primo figliolo, e, come di prammatica, fu chiamato Micuzzo, come il nonno paterno. Il giorno di capodanno, Tuturo, con una cerimonia tutta sua, sollevò il bambino, vestito dell’abito di San Francesco, in alto, come un’offerta votiva, dicendo: “Sii degno di tuo padre e di colui di cui porti il nome”. Così nella gioia dell’intimità familiare fu salutato il nuovo anno.
Il bambino cresceva bello e, nelle lunghe notti invernali, assente Tuturo, Cilla, agucchiando e rammendando le calze al lume della candela, vegliava amorevolmente al capezzale del bambino “membrando i fidati colloqui d’amor”.
Ormai in quella casa regnava la pace. Tutti erano contenti di quello che la Provvidenza mandava a compenso del lavoro e Mico, che ormai era grandicello, fu mandato come mozzo su una paranza. Subito si rivelò accorto e degno dell’arte paterna; a quindici anni era già marinaio di gran vanto. La bravura del giovane marinaio si avvertì un giorno, quando le paranze, scese in mare con la minaita (rete per pesce azzurro), dovettero affrontare un vento di scirocco-levante, che spingeva le imbarcazione in direzione dello Stromboli. Mentre le altre barche dovettero essere rimorchiate da un bastimento di passaggio, quella di Mico tornò con mezzi propri perché convinse la ciurma a non togliere le reti, cariche di pesci, che fecero da ancora.
Verso metà dicembre di quell’anno Tuturo partì con un carico di pastilla (castagne essiccate senza scorza) per Malta e contava che tra andata e ritorno avrebbe fatto in tempo a ritornare per le feste natalizie. Passarono i giorni e quando Cilla, seguendo i suoi calcoli, ritenne essere probabile il ritorno, era là, su quel sasso, a scrutare l’orizzonte, in attesa della vela amica! Nessuna vela e nessuna notizia!
Cosa argomentare? Non avrà trovato prezzo conveniente e sarà partito per altri lidi! Intanto le feste eran giunte. Ella non volle fare il cattivo augurio al marito ed, alla vigilia di Natale, illuminò il presepio e pose intorno ad esso i tanti regali. Cenarono lei ed il figliuolo. Cena triste e monotona. Poi andarono a letto, ma Cilla non chiuse occhio e si ripeteva continuamente la domanda: “Dove potrà trovarsi?”
Passò il Natale, ormai da un pezzo non si avevano notizie e nelle notti insonni, come un terribile incubo, ad occhi aperti, vedeva il marito lottare coi marosi e restarne alfine inghiottito. Per togliere dagli occhi quella triste visione, cercava di rievocare le circostanze più liete di sua vita: il giorno del matrimonio, la nascita del figlio, il suo compleanno, il viaggio in Sicilia, la felicità nascosta qualche tempo prima. Ciò serviva a colmare, sebbene per un attimo, il vuoto che la circondava. Ma, appena giorno, era là, su quella pietra a scrutare l’orizzonte. Stando lì, per ingannare il tempo della sua immobilità, andava ancor con la mente al passato, ma ritornava atroce il ricordo di quel giorno in cui Turi aveva sollevato il bambino verso il cielo…pronunciando quella frase che Cilla, ora, interpretava come un triste presagio! Un avviso della capitaneria di porto di Trapani a padron Peppe portò la triste verità: il tre alberi Speranza del compartimento marittimo di Pizzo, partito da Malta il 22 dicembre, colto da fortunale nel canale di Sicilia, era affondato; nessuna traccia dell’equipaggio.
Cilla ne fu desolata e le venne in odio quel mare che, per anni, era stato così benefico per la sua famiglia ed insisteva col figlio perché lasciasse quel mestiere, causa della sua sciagura e si dedicasse ad altro lavoro. Ma non valsero le preghiere e gli scongiuri. La povera donna dovè piegarsi alla volontà del figlio attirato da una forza irresistibile verso quel tradizionale e rischioso mestiere.
Questo nostro Tirreno, cristallino, generoso ebonario come il volto di un vecchio nonno, diventa, qualche volta capriccioso e traditore! In una delle sue fasi, che la nostra gente marinara chiama “mare vecchio”, sembra calmo e liscio in superficie, mentre agita nel fondo le correnti più contrarie che, venendo su all’improvviso, mettono a grave pericolo le imbarcazioni; ma, quantunque se ne guardi la gente di mare, pure, quando il bisogno urge, bisogna tentare. Successe che, terminata la buona stagione, Mico, d’accordo con la ciurma, decise di tentare con la minaita la pesca delle prime alici. Vararono all’alba ed a cento passi calarono le reti. A prima cala qualcosa era entrato in rete e la giornata prometteva bene. Smagliarono e ributtarono le reti. Ed ecco una forte corrente di libeccio, il mare si fa grosso ed i cavalloni vengono uno dietro l’altro, alti e violenti. Tirare le reti e vogare verso riva, fu tutt’uno. Ma erano troppo distanti e non potettero evitare che la tempesta si scatenasse su di loro con tutta la sua furia.
Cilla era già sulla pietra e, trepidante seguiva la lotta degli uomini contro la furia degli elementi e, quando avvertì la minaccia di quel tempo infernale, fu la prima a dare l’allarme. Chi poté non si risparmiò di correre al lido e dare il proprio aiuto. Mico, che governava bene l’imbarcazione, distava appena un centinaio di metri dalla riva. D’improvvisodue cavalloni alti e potenti, a breve distanza l’uno dall’altro, capovolsero la barca ed i pescatori si trovarono in acqua a lottare con i marosi.
Mico lottava validamente e la madre, disperata correva da un punto all’altro, implorando aiuto per quegli uomini. Ma nessun altro aiuto si poteva dare ai naufraghi se non quello di mollare qualche cima perché l’agguantassero e fossero tirati così a riva. Ma i marosi ributtavano le corde. Si spinse qualche volenteroso più dentro in acqua, lanciò la cima che cadde poco distante da Mico e non poté essere afferrata. Allora Cilla capì che bisognava ancora accorciare la distanza, afferrò un “libonu” (legno) si spinse in acqua quanto più poté e lo lanciò così vicino al figlio che poté afferrarlo e portarsi in salvo insieme al resto della ciurma.
Cilla, però, scomparve tra i marosi. Dopo due giorni il mare ne ributtò il cadavere sulla spiaggia, proprio sotto il castello ed alla base di quella pietra che, nelle lunghe attese, fu causa di gioie e di tormenti. La povera madre, in vista del suo altare, aveva compiuto l’ultimo e supremo sacrificio. Il grido lacerante si sente ancora nelle notti tempestose, col disco plasmato nell’etere e ripetuto dal mistero. È l’appello disperato di Cilla che domanda aiuto per la sua pericolante creatura.