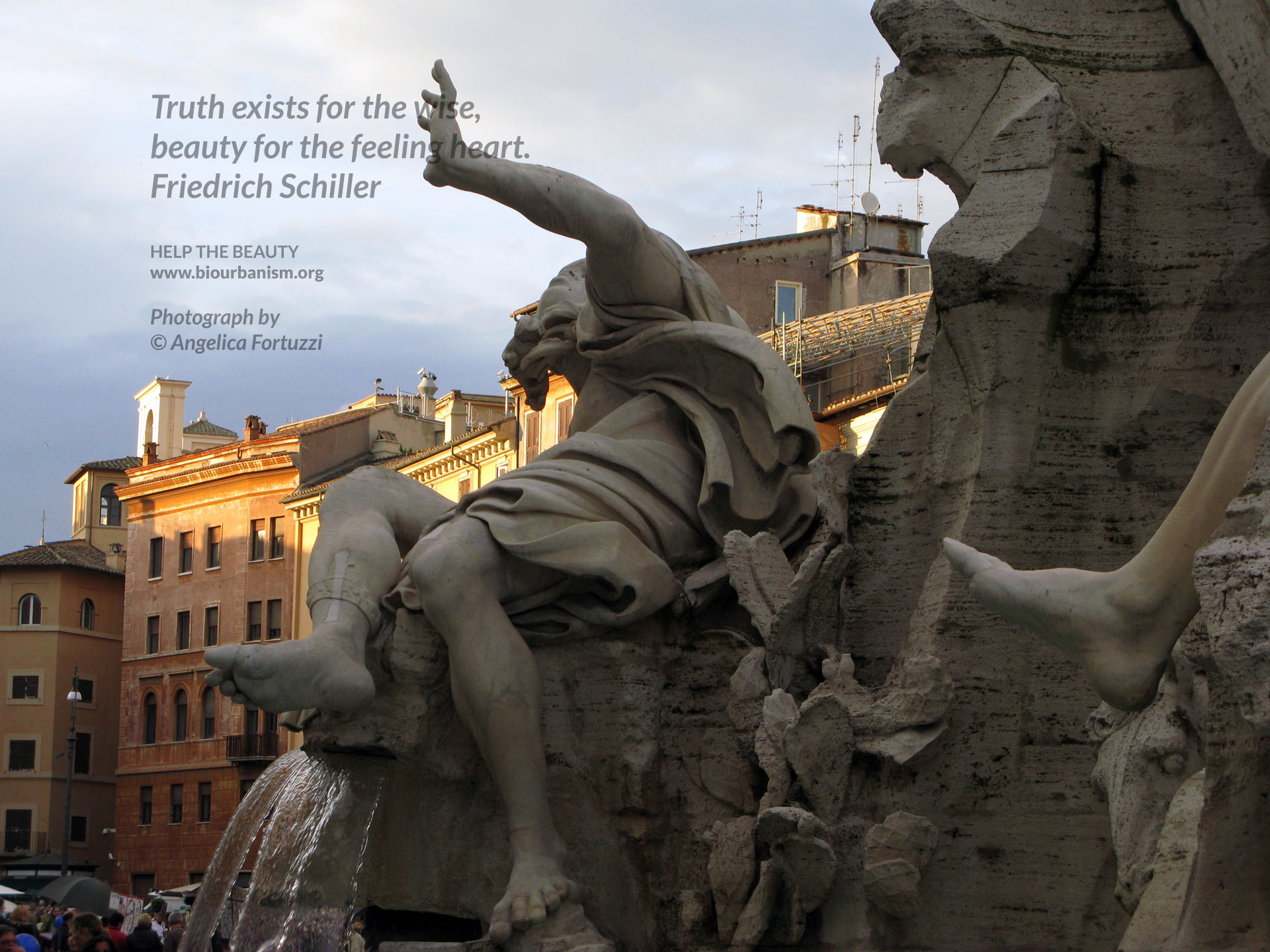MAK di Vienna mostra "Eastern Promises"
di Angelo Abbate
Al MAK di Vienna è aperta fino al 6 ottobre la mostra "EASTERN PROMISES contemporary architecture and spatial practices in east Asia", un'esibizione di lavori molto interessanti per tema e raffinatezza espressiva dei partecipanti in molti casi giovani alla prima esperienza di esposizione in pubblico.
La cultura architettonica contemporanea ci ha abituato a kermesse celebrative di un sistema consolidato di autori famosi che da più di vent'anni propongono e ripropongono un'architettura tanto ammaliante quanto sterile in termini di innovazione sociale e strutturale. In giro per le varie capitali globalizzate non si fatica a trovare la personale del super-architetto che nelle diverse declinazioni culturali espone le proprie ricerche stilistiche dall'animo mai troppo differente dal suo qualsivoglia collega d'oltre oceano.
Fortunatamente però scintillano altrove altri filoni di ricerca molto meno chiassosi e chattati nelle università di architettura che riflettono con i propri progetti sulle relazioni sociali e sui cambiamenti strutturali verso i quali la società globalizzata contemporanea ci sta portando. Un laboratorio consapevole sul futuro dell'architettura non più concentrato semplicemente su un'estetica progressista e spettacolare bensì su una coscienza sensibile e propositiva verso le realtà ambientali e relazionali dell'uomo contemporaneo.
L'esposizione al MAK raccoglie proprio queste intenzioni e nonostante l'altissima qualità dei lavori presentati e l'intelligenza con la quale è stata strutturata e curata l'intera mostra non gode del dovuto risalto tra le testate specializzate e di settore.
La raccolta muove da un pretesto geografico che, considerando Vienna come estremo occidente della vasta area del continente asiatico chiusa ad est dal Giappone, associa interventi dalle sensibilità cruciali nel gestire spazi e risorse sempre più centellinati. Si scopre in questo percorso come il continente delle mega strutture coltivi episodi interessantissimi di architettura delicata e biofilica che centra la sua ispirazione nelle necessità relazionali e biologiche dell'uomo contemporaneo confrontandosi con le reali condizioni del contesto territoriale e sociale. Non è probabilmente un caso se proprio dalla cultura orientale emerga decisa una declinazione "nuova" del fare architettura ricalcando la spiritualità profonda di civiltà millenarie da sempre custodi di un punto di vista sacro sulla vita e sulla natura.
La mostra racconta e definisce i quasi settanta progetti provenienti da quattro grandi Paesi d'Oriente (Cina, Taiwan, Corea del Sud e Giappone) con schede, foto e modelli tridimensionali e in modo intrigante indicizza ciascun lavoro in quattro temi/parole chiave visualizzati iconograficamente come barre di caricamento percentuale secondo un brillante ed efficace richiamo al linguaggio della comunicazione internet. In questo modo, ad esempio, a colpo d'occhio viene descritto l'intervento sperimentale della Ruin Academy di Marco Casagrande a Taipei come 75% di "casa come pianta", 70% di "fascino del rudere", 85% di "uso temporaneo" e 75% di "accademia anarchica" oppure le casette visionarie di Terenobu Fujimori in Giappone come 60% di "otaku" (cultura manga), 25% di Hundertwasser (l'artista austriaco), 50% di "architettura senza architetti" e 65% di "castello nel cielo" e così via tutte le 69 presentazioni.
Quando lasciamo il MAK e riprendiamo la metropolitana (non essendo stati tra i fortunati ad averlo raggiunto in bicicletta) continueremo a pensare che ci è stata raccontata un'affascinante storia realizzabile dove il recycling architettonico e urbano è la chiave giusta per l'interpretazione del futuro delle nostre città e che esso diviene "UPcycling" nel momento in cui l'operazione riscatta e migliora la condizione del luogo e dei suoi abitanti.