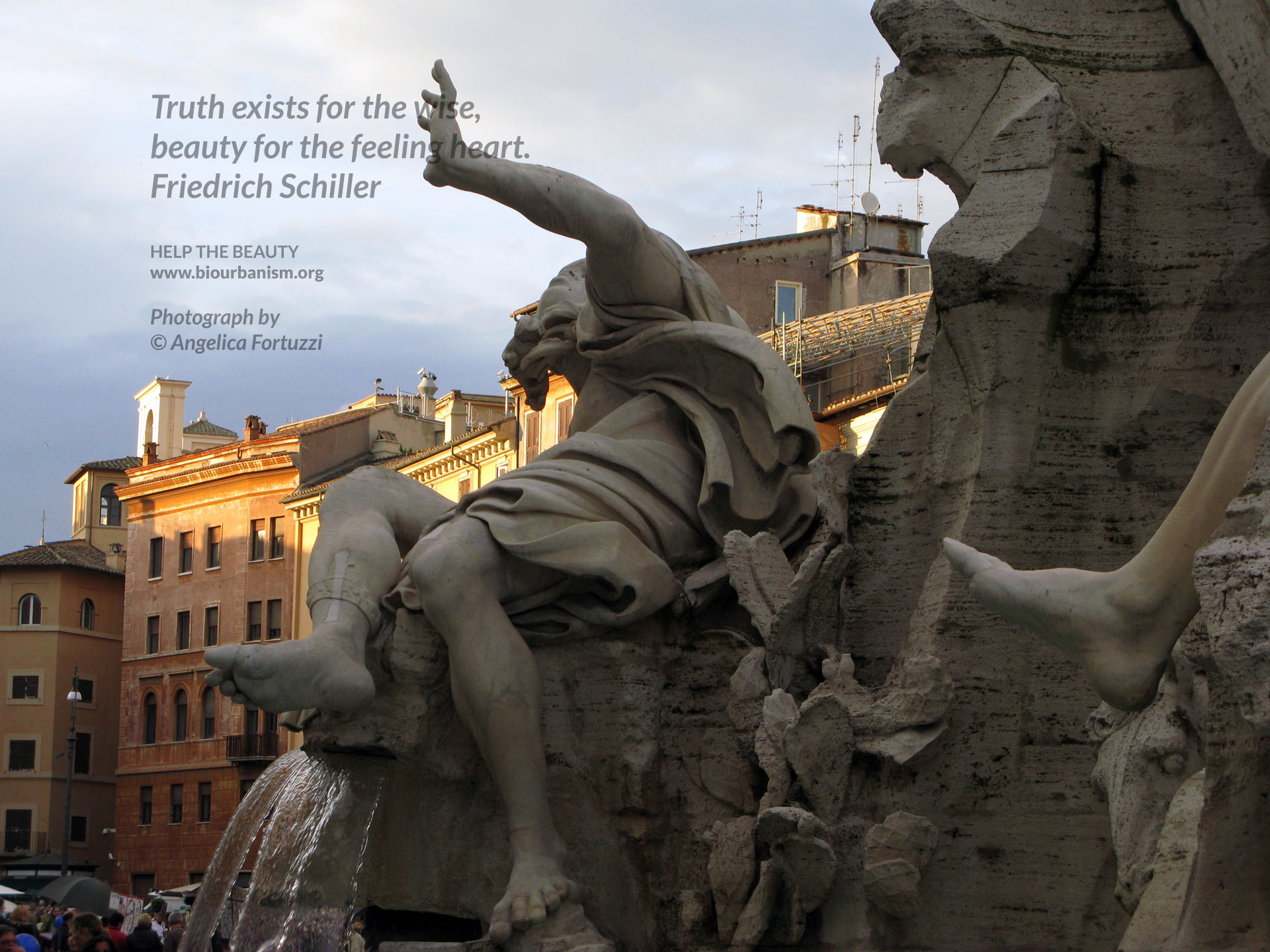Cibernetica e l'arte di vivere
di Ernst Von Glasersfeld
[Plenary address, 13th European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Vienna, April 9-12, 1996]
Volevo iniziare questa conversazione, come si fa spesso per rompere il ghiaccio in una conferenza, divertendovi con qualche battuta ironica. Ma il triste annuncio del Prof. Trappl mi ha messo in uno stato di shock.
Essendo stato in viaggio nelle ultime due settimane, non avevo avuto notizia della morte di Gordon Pask fino a questo momento – e la perdita è decisamente troppo grande per comprenderla. Gordon mi sostenne generosamente circa trent’anni fa’ quando entrai all’Università negli Stati Uniti, e le sue idee non smisero mai di aiutarmi nello sviluppo del mio pensiero. Ed ora sono schiacciato dal profondo dolore per un amico che se ne è andato e che non ho ringraziato abbastanza per l’ispirazione che mi ha fornito.
Così permettetemi di iniziare il mio intervento dicendo che sinceramente spero che uno studioso competente raccoglierà e ricorderà la storia dei primi dieci, quindici anni della cibernetica prima che la maggior parte degli affascinanti aspetti personali e intellettuali dei primi cibernetici siano irrimediabilmente dimenticati. Sfortunatamente io sono tutto fuorché uno studioso competente. Ho solo avuto la fortunata opportunità, come un outsider, di essere testimone dello sviluppo di questa rivoluzionaria disciplina che mi ha profondamente influenzato. Il punto che mi colpì, agli esordi, fu che i padri fondatori, specialmente Norbert Wiener e Warren mcCulloch, pensavano alla loro impresa non solamente come a una tecnica, ma anche come a un nuovo e potente approccio alla filosofia. Ma i due interessi si divisero rapidamente, e lo spettacolare successo matematico e tecnologico che la cibernetica ha ottenuto fino ad oggi, ha completamente nascosto il potenziale filosofico.
Giudicando dai simposi annunciati dal nostro programma odierno, anche il focus di questa conferenza, è ampiamente dedicato alle innovazioni tecniche e alle nuove applicazioni in una grande varietà di settori. Per cui mi sto assumendo un po’ di rischio parlando di cibernetica e dell’arte di vivere. Posso solo sperare che alla fine mi perdonerete. Voglio cominciare richiamando un’affermazione di McCulloch fatta durante una lezione all’università della Virginia nel 1948 : “aver provato che un’ipotesi è falsa”, diceva, “è infatti il picco della conoscenza”. Il mondo reale non ci mostra quando abbiamo ragione ma quando abbiamo torto. Tutto quello che sperimentiamo sono i vincoli che ci impediscono di agire in certi modi. Quando leggevo lo scritto di McCulloch erano i primi anni sessanta, io ero già da lungo tempo profondamente insoddisfatto della tradizionale epistemologica. L’affermazione fu una rivelazione. Più tardi m’imbattevo nello scritto di Gregory Bateson sulla “spiegazione cibernetica” ( 1972 ) nella quale egli spiegava che ciò che rende differente la cibernetica dalle altre imprese scientifiche è il fatto che opera con vincoli piuttosto che con cause efficienti. Egli citava la teoria dell’evoluzione come un primo esempio, perché la selezione naturale elimina soltanto ciò che non è adatto. Le proprietà che permettono ad un organismo di sopravvivere non sono create dalla selezione naturale ma sono il risultato di variazioni casuali.
La teoria dell’evoluzione si applica alle specie ed alle proprietà ereditabili che le caratterizzano. Le specie non hanno conoscenza, esse sono ciò che sono, e gli organismi che compongono le specie hanno o non hanno le proprietà che gli permettono di sopravvivere. Ma ci sono molti organismi che noi chiamiamo intelligenti, perché sono in grado d’imparare dalla loro esperienza. Quello che imparano, naturalmente, non è ereditabile, ma potrebbe aiutarli a sopravvivere. Essi imparano ad evitare alcuni vincoli del mondo che essi sperimentano. In altre parole, imparano ad adattarsi meglio fra gli ostacoli che il loro ambiente mette sul loro percorso. Se uno prende questa idea dell’adattamento e l’applica al problema di come noi ci guadagniamo la conoscenza sulla base di come noi cerchiamo di condurre le nostre vite, si giunge ad una teoria della conoscenza che è radicalmente differente dalle principali epistemologie della tradizione filosofica. Dato che Vienna è spesso considerata una roccaforte “dell’epistemologia evolutiva” voglio sottolineare che il modello cognitivo di cui stò parlando non si adatta a quello. La principale ragione è che la conoscenza nel modello cibernetico non è mai conoscenza di un mondo reale. È conoscenza di quello che uno può o non può fare. Gli ostacoli che si manifestano come vincoli, sono semplicemente i limiti dello spazio che è accessibile all’esperienza. Essi sono relativi al modo in cui l’organismo fa esperienza, non la rappresentazione di una realtà indipendente. La conoscenza, in questa teoria, non è quindi un’immagine della realtà ma un repertorio di azioni e pensieri che in precedenti esperienze sono risultati essere di successo. In questo senso, questa teoria della conoscenza sostituisce la nozione di rappresentazione vera con la nozione di viabilità. Piuttosto che addentrarci nei dettagli di quella teoria che è spiegata in altro luogo (Glasersferld 1995), vi darò alcuni esempi concreti di come io la vedo. Ho passato gli ultimi dieci giorni a Chamonix e sulle montagne intorno al monte bianco. E stata un’esperienza nostalgica, perché quarant’anni fa passavo molte primavere sciando sui ghiacciai delle alpi. In quei giorni non c’erano cabinovie e altri mezzi meccanici per trasportare migliaia di sciatori sulla cima delle montagne. Eravate soli là e se volevate sciare giù per la montagna, dovevate prima scalarla.
In retrospettiva, mi colpì come buon esempio, di come affrontare dei vincoli. Se volete andare su o giù per una montagna dovete guardarla attentamente. Se volete raggiungere la cima, potrebbe essere un errore cercare la via più semplice per salire. Come un esperto montanaro, per prima cosa dovete capire dove non dovete andare. Dovete cercare di vedere possibili valanghe, cadute di ghiaccio, crepacci di ghiaccio e altri fatali vincoli. Soltanto quando avete per così dire, buttato giù uno schema dei tracciati pericolosi della montagna, potrete iniziare il vostro piano per scalarla. A questo punto, dovrete fare delle scelte, ma le farete all’interno dello spazio, lasciato tra i vincoli della montagna. “Conoscere” una montagna significa sapere dove, sul suo pendio, sarete relativamente al sicuro; questo significa aver imparato un percorso viabile.
Si può arrivare alla nozione di viabilità in molti modi. Uno di questi è il principio che Leibniz e Maupertuis formularono molto tempo fa: il principio dell’ultima azione o rispettivamente, dell’ultima resistenza. L’acqua seguirà la spinta della gravità fin che può. Quando piove su di una collina, l’acqua della pioggia corre giù dovunque trovi il modo. Se arrestata, si raccoglierà ed eventualmente fluirà oltre o intorno all’ostacolo. Questo, a sua volta, cambia il profilo della collina rendendo viabili nuovi percorsi e incontrabili nuovi vincoli. Ma lasciatemi tornare alle origini della cibernetica. Oltre a passare il focus dell’attenzione dalle cause ai vincoli la cibernetica conduce ad un altro fondamentale cambiamento varando la teoria della comunicazione. Quando Claude Shannon formulò matematicamente la teoria si preoccupò di affermare nelle prime due pagine del suo scritto che ciò che lui chiamava “informazione” non aveva niente a che fare con la semantica. Gli impulsi che viaggiano in un canale comunicativo da una sorgente a un ricevitore sono cambiamenti di qualche forma di energia. Essi sono “segnali” solo per quelli che sono in possesso del relativo codice. Il codice stesso non è parte della trasmissione. I segnali sono istruzioni per selezionare specifiche parti del codice. E “informazione”, nella teoria della comunicazione, non si riferisce al significato degli elementi codificati, ma è semplicemente la misura di quanto o quanto poco dei prestabiliti elementi il segnale seleziona.
Voi probabilmente sapete tutto questo, ma è bene ricordarlo quando qualcuno sta parlando.
Norbert Wiener fornì il meraviglioso esempio dei negozi di fiori che usano il proprio sistema economico di comunicazione. Se un giovane ragazzo a Vienna passa alcuni giorni felici con una turista americana, e adesso che lei è partita, vuole approfondire l’impressione che ha fatto su di lei, egli potrebbe andare in un negozio di fiori e ordinare una dozzina di rose rosse da far spedire a lei a Los Angeles per il suo prossimo compleanno. Il negozio di fiori allora telegrafa l’indirizzo, il nome del mittente, e un numero specifico diciamo 54. Attraverso questi due semplici numeri istruisce il negozio ricevente affinché selezioni dodici rose rosse e il messaggio “buon compleanno”.
Non pensate che io abbia fatto questo così spesso da sapere a memoria il codice dei fiorai. Ho solo inventato il numero 54. Ma i fiorai usano numeri simili per selezionare specifici fiori ed ogni tipo di auguri e condoglianze.
La mia intenzione parlandone qui è semplicemente quella di dire che il numero è insignificante a meno che non sia interpretato o decodificato da una persone che conosce il codice. L’”informazione” che il numero trasporta in questo contesto, non è niente più che quello che indica e quindi seleziona un item particolare fuori da tutti i messaggi che il codice dei fiorai contiene. Questa condizione fondamentale sfortunatamente fu trascurata da quasi tutti i linguisti che vennero presi da una frenetica eccitazione quando udirono della teoria di Shannon, e prontamente combinarono la loro confusione parlando di “teoria dell’informazione”, mentre Shannon l’aveva deliberatamente chiamata “teoria della comunicazione”. Il linguaggio umano è, naturalmente, un sistema di comunicazione e fu alquanto illuminante applicargli la teoria di Shannon. Ma il linguaggio è anche diverso da tutti i sistemi tecnici o artificiali di comunicazione. La differenza cruciale è che nel linguaggio noi non partiamo con un prestabilito codice, ma ognuno di noi lo impara usandolo.
Potreste dire che è un non senso, perché abbiamo dizionari che ci dicono i significati delle parole. Vero, abbiamo i dizionari, ma come fanno a dirci i significati delle parole che ci cerchiamo? Essi usano altre parole. Pensate solo per un momento quanto otterreste se doveste imparare l’alfabeto morse cercando di usarlo.
Un bambino di un anno, nel processo di acquisire la lingua, è quasi nella stessa difficile posizione. Dico “quasi” perché c’è un’importante differenza: la lingua che il bambino deve imparare è stata usata dai parlanti costantemente nel campo dell’immediata esperienza del bambino. Un esempio può aiutarmi a mostrare cosa intendo. Lasciatemi dire che una mamma dice al suo bambino : “È tempo del tuo biberon.” Lei va a prendere il biberon, mette la tettarella nella bocca del bambino e dice: “bevi il tuo latte!” Il bambino comincia a succhiare (perché lui succhia ogni cosa che tocca le sue labbra ) e sente il liquido nella sua bocca. Nessun dubbio che egli formi delle associazioni fra il suono delle parole, il tocco della tettarella sulle sue labbra, e la sensazione nella sua bocca. Ma gli ci vorranno molte altre esperienze, bevendo acqua o succo di frutta, con tazze e bicchieri e con molti altri suoni-parole prima che il bambino selezioni i significati approssimativi di “biberon”, “bere”, “latte”.
L’aspetto più importante di questa situazione d’apprendimento è questo: l’esperienza del biberon, del bere e del latte con cui il bambino associa i suoni di queste parole, sono impressioni soggettive del bambino. Esse non sono né della mamma né di nessun altro. Nemmeno sono “cose in sé stesse” o prove di oggetti indipendenti nel mondo reale. Non possono essere qualsiasi cosa ma solo le impressioni che a questo soggetto-bambino capita di sperimentare.
Chiaramente, nel caso di parole che sono usate spesso nel linguaggio quotidiano, queste impressioni soggettive diventano più o meno intersoggettive nel corso delle interazioni linguistiche con altri parlanti. Ma si può mostrare che anche le parole più comuni conservano un margine di soggettività per ogni individuo parlante. Linguisti e filosofi del linguaggio, normalmente racchiudono questo margine sotto il vocabolo “connotazione”, e affermano di essere in grado di separare la componente semplicemente soggettiva dalla “oggettiva denotazione”. Dal nostro punto di vista, questa affermazione si poggia sull’illusione che le parole si riferiscano a cose in un mondo reale. Nella nostra teoria, che naturalmente consideriamo più adeguata, le parole, come spero di avere mostrato sopra, si riferiscono a esperienze soggettive dell’individuo che sta usando il linguaggio. La separazione fra denotazione e connotazione perciò, non implica più oggettività, ma diventa una questione di maggiore o minore aderenza all’uso che ne fanno gli altri parlanti. Il risultato della nostra ricerca in quest’area è che il significato delle parole e di segmenti più lunghi del linguaggio, non sono mai “condivisi” con altri, nel senso che potrebbero essere considerati gli stessi per tutti i membri di una comunità linguistica. Tutto quello che possiamo dire è che fra parlanti esperti di una lingua, i significati sono al massimo compatibili, cioè funzionano similmente in molte situazioni. Questa è una differenza importante rispetto ai sistemi di comunicazione tecnici e artificiali. Là, il codice che attribuisce il significato ai segnali, è stabilito e distribuito ai comunicatori prima che ogni comunicazione abbia luogo. Al contrario, un bambino acquisisce i vocaboli del linguaggio umano incontrando un sistema che è già attivo e come nuovo arrivato egli deve stabilire un codice per se stesso (se stessa). Questo è un processo laborioso che comporta innumerevoli tentativi ed errori e conduce al massimo ad approssimazioni viabili. Infatti, è un processo senza fine. Non importa quanti anni hai e da quanto tempo stai parlando la tua lingua, prima o poi scopri che stavi usando una parola particolare in un modo che non è compatibile con l’uso accettato dalla tua comunità. Eri inconsapevole della idiosincrasia, semplicemente perché la situazione in cui la discrepanza diventa rilevante non si era verificata nella tua passata esperienza.
In superfice sembra che questo abbia poco a che fare con l’arte di vivere, ma è ovviamente un fattore nell’arte di leggere. Quante volte aprite un libro su un argomento intellettuale, e nelle prime poche pagine incontrate affermazioni che sembrano insensate. Se siete lettori impazienti, potreste dirvi, questo autore è folle, e buttare via il libro. Ma invece, se vi ricordate che i significati delle parole sono essenzialmente dei costrutti soggettivi degli individui che usano il linguaggio, tenderete a trattenere il giudizio. L’autore, vi direte, si suppone sia intelligente e quindi è probabile che quanto egli o ella abbia scritto, abbia senso per lo scrittore. In questi casi farete uno sforzo per far saltare fuori quale potrebbe essere questo significato. Quasi sempre un tale sforzo è ben fatto, perché conduce a capire che il testo non solo usa termini in un modo non famigliare, ma che un nuovo modo produce validi significati. Ogni volta che riuscirete a farlo, avrete imparato qualcosa di nuovo, e questo, dopo tutto, è lo scopo più profondo della lettura.
Quanti dibattiti filosofici potrebbero trasformarsi in discussioni produttive, se solo i partecipanti non fossero convinti che il significato che essi hanno associati con le parole siano i soli significati legittimi. Quanti dilemmi tra amanti potrebbero essere evitati, se uno dei due considerasse che quello che l’altro dice potrebbe non significare ciò che sembra significare. Tutto questo, naturalmente, fa nascere una domanda su cosa intendiamo quando diciamo che abbiamo capito un discorso. È ancora molto diffusa l’idea che le parole contengano i loro significati allo stesso modo in cui i libri contengono le pagine. Se, tuttavia, le parole sono segnali stampati o parlati nel sistema linguistico della comunicazione, esse non possono trasmettere un significato fissato. Esse possono solo indicare e selezionare una qualunque cosa il lettore o l’ascoltatore abbia loro associato. E le strutture interpretative che quella persona ha associato con quelle date parole sono estrazioni dall’ esperienza personale di quell’individuo, non dall’esperienza dello scrittore o del parlante. Senza dubbio ogni associazione linguistica del parlante è stata adattata e affinata in anni di interazione linguistica con altri parlanti, ma il materiale di cui esse consistono è in ogni circostanza frutto di un’esperienza soggettiva.
Che cos’è, allora, la comprensione?
Voglio suggerire che comprendere dipende dal senso che voi date a ciò che è detto o scritto. Se i concetti che le parole vi hanno richiamato, e il modo in cui la frase vi ha portato a metterli in relazione, producono una rete concettuale che si adatta al contesto creato da quanto vi è successo in precedenza e non è annullato da qualsiasi cosa che il parlante dice o fa adesso, allora voi assumete di aver capito quanto ella o lui intendevano. Questa, ovviamente, è una semplificazione. Ciò che ho chiamato contesto è usualmente una gerarchia di differenti livelli contestuali, come le vostre passate esperienze con chi parla o con l’autore, le vostre proprie interpretazioni del mondo esperienziale in generale, certe aspettative che vi siete formati, e altre cose del genere. Tuttavia, il punto che voglio enfatizzare è che ad ogni livello è una questione di adeguatezza – non una questione di ricevere o riprodurre strutture concettuali che sono originate nella testa di chi vi parla. Quello che chi vi parla o l’autore vogliono dire è sempre inaccessibile – voi potete solo interpretare quello che lui o lei hanno detto adesso. Potreste domandarvi perché abbia speso tanto tempo parlandovi del linguaggio. Ho due motivi. Il primo è che gran parte del nostro vivere lo facciamo in compagnia di altre persone, e il linguaggio è inseparabile dal contesto sociale. Di conseguenza sento che un modello coerente di come la comunicazione linguistica funziona è un grande aiuto nel gestir le nostre interazioni sociali e quindi, la nostra vita.
Renderebbe la nostra vita più piacevole, ad esempio, se ogni tanto uno che sta per urlare a qualcuno: “Ma ti ho detto così!” si ricordasse che dire non garantisce di essere compreso. Il secondo motivo è che il principio interpretativo dell’ “adattamento viabile”, che ho messo in evidenza in riferimento alla comprensione del linguaggio, è ugualmente applicabile per capire il mondo in cui noi ci troviamo a vivere. Non abbiamo più accesso ad una realtà ontologica di quanto ne abbiamo ai pensieri di un’altra persona. Tutto quello che abbiamo per andare avanti sono le nostre esperienze. In entrambi i casi, noi interpretiamo quello che vediamo, ascoltiamo, sentiamo, e costruiamo modelli che ci permetteranno di fare previsioni. In una precedente edizione di questa conferenza, qualche anno fa, suggerii che se il modello che abbiamo costruito della persona con cui viviamo insieme, ci è stato utile per un po’ di tempo, tendiamo a credere di aver capito come quella persona è. Ma prima o poi il nostro compagno farà qualcosa che noi non ci aspettavamo. Questo potrebbe irritarci, e noi potremmo rimproverarlo: “Sei cambiato!”; spesso non è il caso. L’altro ha semplicemente mostrato un aspetto che non avevamo incorporato nel nostro modello, perché nessuna situazione precedente l’aveva fatto saltare fuori. La nostra sorpresa e la nostra irritazione dovrebbero essere molto mitigate dal tenere in mente che l’altro che conosciamo, non è l’altro come lui o lei sono, ma un modello che abbiamo costruito sulla base di niente altro che la nostra esperienza. La stessa identica cosa succede agli scienziati che costruiscono un modello di, diciamo, sistema planetario o dell’universo. Se quel modello funziona bene e produce risposte utili alle domande che gli sono poste, finisce per essere considerato come la vera descrizione della realtà. Ma presto o tardi qualcosa di incompatibile sarà osservato, una precessione di Mercurio o un raggio di luce che non segue la linea retta. Tali osservazioni costituiscono dei limiti che demoliscono la viabilità accettata del modello. Il modello non si adatta più alle nuove esperienze del mondo degli scienziati. All’inizio c’è normalmente un po’ di incredulità e moltissima riluttanza nell’accettare tali fallimenti. Col tempo, tuttavia, un nuovo modello sarà costruito con l’aiuto dei nuovi concetti che fanno sembrare, le precedenti osservazioni scioccanti, normali e prevedibili. Tutto questo è in armonia con il principio fondamentale della nostra disciplina, per i cibernetici, cioè l’arte di creare equilibrio in un mondo di possibilità e vincoli. Vorrei suggerire che questo è anche una definizione viabile dell’arte di vivere.
Bibliografia
Bateson, G. (1972) Cybernetic explanation. In Bateson, Steps to an ecology of mind, (pp. 399-410). New York: Ballantine.
Glasersfeld, E. von (1995) Radical constructivism: A way of knowing and learning. London: Falmer Press.
McCulloch, W.S. (1948) Through the den of the metaphysician. In McCulloch, Embodiments of mind, (pp.142-156) Cambridge (Massachusetts), M.I.T. Press, 1965.
Shannon, C.E. (1948) The mathematical theory of communication. Bell Systems Technical Journal, 27, 379-423 & 623-656.
Pubblicato in: Glasersfeld, E. von (1996) Cybernetics and the art of living. Cybernetics and Systems, 27 (6), 489-497. Traduzione autorizzata dal Prof. Glasersfeld a cura del dott. Ivan Paolo Bolognesi.